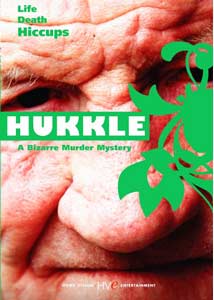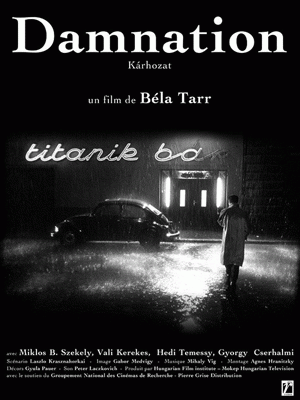VENERDI 5 FEBBRAIO 21.30
KARHOZAT
(dannazione)
(ungherese subtitle italiano)
Di Béla Tarr

Anno: 1987
Nazionalità: Ungheria
Sceneggiatura: Laszlo Krasznahorkai, Béla Tarr
Fotografia: Gabor Medvigi
Montaggio: Agnes Hranitzky
Musica: Mihali Vig
Durata: 116 min.
Cast: Miklos B. Szekely, Vali Kerekes,
Gyula Paver, Hedi Temessy


Karrer vive già da anni come tagliato fuori dal mondo, lontano da tutto. Passa il suo tempo osservando le benne della teleferica che si allontanano all’orizzonte, o vagabondando senza meta, sotto una pioggia incessante, per chiudere invariabilmente le sue giornate, qualunque sia la direzione presa la mattina, nella medesima taverna. Un giorno decide di coinvolgere nei suoi loschi affari il marito della cantante del Bar Titanic, per poter così avvicinare la giovane donna. Riesce ad allontanare l’uomo per qualche giorno, con la complicità di Willarsky, suo amico e proprietario del bar. Gli slanci affettivi mutevoli che caratterizzano i rapporti tra questi quattro personaggi indissolubilmente legati gli uni agli altri dai loro interessi e sentimenti, provocano tra di essi conflitti e ravvicinamenti disperati. Sarà Karrer a uscirne sconfitto; a lui non resterà che l’odio e il desiderio di vendetta. Le tappe del suo calvario lo porteranno non alla redenzione, ma a ciò che rappresenta il peggio per l’uomo europeo: la morte che precede la morte, la solitudine totale, il naufragio nella perdizione…
raitre.rai.it


Perdizione è un film che racconta la caduta, un mondo dove tutto - la luce, gli oggetti, il clima, gli interni, i volti, la musica - trasuda di sofferenza, di fatiscenza; dove il tempo sembra regredire e lasciare il posto alla decomposizione. Un mondo senza futuro, senza cambiamento, dove due corpi che si amano sembrano quasi agonizzare, mentre il loro riflesso nello specchio è già un segno di separazione e di morte. Pure un momento di evasione e di spensieratezza come il ballo si trasforma in un agglomerato di movimenti trattenuti, di sguardi attoniti e ripiegati, nei quali si rivela una timidezza rassegnata. In uno spazio così pesantemente ristretto e disadorno, che alla fine si svuota in un disordine che non fa pensare al divertimento, ma è fatto dei rifiuti lasciati dall'impossibilità di godere, pur nella crudeltà oggettiva, dei piccoli piaceri che i comuni mortali inventano anche nelle situazioni più tristi. Si pensi alla bellissima sequenza della gente accalcata alle porte, mentre guarda la pioggia, con la macchina da presa che carrella lentamente, seguendo la parete. Un inserto apparentemente inessenziale sul piano narrativo, ma che realizza il senso di una vana, quanto inverosimile attesa.
L'occhio della macchina si erge a giudice di quegli sguardi, quando preclude ogni possibile oggetto di visione, sottolineando anzi l'energia dell'assenza, e quando li esclude materialmente, scivolando su un muro, la cui evidenza, la cui rugosità si trasformano in una sorta di cancro visivo; materia che cerca quasi di inghiottire il potere stesso della visione e dell'analogia. Al di là dell'eventuale indicazione metaforica, quel muro rappresenta l'altro dell'immagine in maniera corrosiva, tendente ad annullare una distanza che, in ogni caso, sarebbe una garanzia per il potere sublimante dell'espressione.
Angelo Signorelli, "Cineforum"


Béla Tarr compie in tal senso un'operazione chirurgica sulla concretezza della riproduzione cinematografica, che si traduce anche in una profonda interrogazione sulla bellezza. Ad una materia devastata, quale si è indicata prima, egli oppone una ricerca formale la cui meticolosità va di pari passo con l'intenzione di plasmare un'armonia e un'intensità visive che, senza togliere al referente la sua desolata consistenza, tengano in vita, nell'indicarne la possibilità, l'idea di un superamento "spirituale", di uno stupore del linguaggio, di un'utopia astratta, che sgretolano l'oggettività e ritrovano l'urgenza della creazione soggettiva. La visione del mondo non si riduce in tal modo a semplice interpretazione, ma richiama a sé la trasformazione dei segni, inventando il bello nell'esaltazione fotografica, nella suggestione sonora, nell'attrito esistenziale dei personaggi, nella drammatizzazione dei luoghi, e poi nelle costruzioni della macchina da presa, che spesso riesce a "pensare" la finzione con quel suo scorrere nello spazio, come a voler assolutizzare l'apparenza e traslarla nell'infinita variabilità dell'immagine. È questo un cinema che accetta il rischio della negazione anche sul piano della soddisfazione narrativa; i tempi del racconto non guidano la messa in scena, nel senso di una disposizione strutturale, ma è la presenza cinematografica a dettare i ritmi dell'esposizione. In questo modo la storia non viene confermata dal racconto, ma rimane frantumata, in lontananza, lasciando spazio sia alla riflessione che alla sensazione, le quali danno corpo ad una percezione amplificata, con una fortissima tensione tra quanto viene rappresentato e l'espressione che ne lavora la presenza. Lo stesso rapporto analogico non soddisfa più solo ad un'esigenza di riconoscimento; anch'esso viene sottoposto ad un "trattamento" che, nell'esasperarlo, in realtà lo riduce nella sua evidenza fenomenologica, diventando così esso a sua volta motivo di un processo di pensiero superiore. E qui si arriva al problema centrale di Perdizione: il tempo della rappresentazione. Il film procede per piani sequenza, che riducono il movimento della narrazione e che sembrano obbedire a tempi reali di svolgimento delle vicende. Quando la donna canta la sua canzone, la macchina da presa "rispetta" la durata del pezzo, muovendosi nel locale come a voler riprendere la totalità degli eventi in atto: la scena nelle sue disposizioni spazio-temporali, ma anche i sentimenti, le lacerazioni, i pensieri, i disagi interpersonali. È una lettura ingrandita di ciò che viene visto. In realtà la rinuncia all'elusione temporale nella formazione drammatica, l'aggiramento dell'ellisse rendono il cinema di Béla Tarr metafisico; esso cioè arriva ad assorbire completamente la realtà ed a rifrarla entro un processo ontologico di visione, che attribuisce appunto all'occhio artificiale un potere totalizzante che va oltre lo sguardo del soggetto. Si pensi infatti al ripetersi della circolarità interna nei singoli momenti; non è possibile infatti parlare di vero e proprio montaggio nei piani sequenza, nel senso almeno di una costruzione per piani, di un cambiamento dell'inquadratura che scandisca la necessità del significato. Qui il cinema non si predispone al compromesso per dare alla rappresentazione e allo spettatore la sintesi temporale che conservano il trucco della verosimiglianza e la garanzia dell'impressione di realtà. È invece un tempo "interminabile" poiché potenzialmente illimitato, che ritrova una sua riduzione nell'imporsi alla materia in cui si "realizza". In ciò si fa meditazione, autocoscienza, esplorazione riflessiva.
Angelo Signorelli, "Cineforum"


Perdizione si svolge in una dimensione tragica, ma nei limiti del ripiegamento dell'oggi. Si potrebbe parlare di tragedia della decadenza; dove il coro si esprime nel volto terreo di una guardarobiera, dove la lotta dell'eroe si conclude miseramente in un campo di rifiuti, tra i cani che rovistano e le pozzanghere che riflettono una luce livida, dove il fato dimora nelle stanze nude di un commissariato di polizia. Dove la sconfitta non significa nobiltà, la grandezza di chi combatte contro forze superiori ma con la disperata volontà della propria coscienza spezzata. Qui la sconfitta è sostanza storica, immersione nel tempo ordinato, imposto da divinità tanto oggettive da sembrare ormai ovvie, contro le quali non è possibile neppure usare più le contraddizioni del linguaggio, la critica della forma. In questo senso Perdizione è un film paradossale, poiché si sviluppa tra la trascendenza di una bellezza che nel segno apre infinite possibilità e l'immanenza di una negatività assoluta, che nell'immagine vuole imporre qualsiasi mancanza di futuro. Il significato tragico del film forse sta proprio in questa lacerazione estrema, che l'artista di oggi raramente è in grado anche solo di riflettere; la tragedia la si sconta ormai con la moneta del servilismo e dell'impotenza. Ma la grandezza di Perdizione è anche in questa sua carica provocatoria, per un cinema che sfida e sconvolge lo spettatore "combinando" il disagio con l'esaltazione estetica.
Angelo Signorelli, "Cineforum"

VENERDI 12 FEBBRAIO 21.30
WERCKMEISTER HARMONIAK
(armonie di WERCKMEISTER)
(ungherese subtitle italiano)
Di Béla Tarr

Anno: 2000
Nazionalità: Ungheria / Italia / Germania / Francia
Sceneggiatura: Béla Tarr, Laszlo Krasznahorkai
Fotografia: Medvigy Gabor, Robert Tregenza, Novak Emil,
Jorg Widmer, Patrick de Ranter, Miklós Gurban
Montaggio: Agnes Hranitzky
Musica: Mihaly Vig
Durata: 145 min.
Interpreti principali: Lars Rudolph, Peter Fitz, Hanna Schygulla


Una piccola città di provincia nella pianura ungherese. Nonostante il freddo centinaia di persone stazionano attorno a un enorme camion parcheggiato in mezzo alla piazza, dove aspettano di vedere l’attrazione principale, la carcassa imbalsamata di una vera balena. M. Eszter, un uomo anziano, espone una teoria musicale che mira a ritrovare un’armonia superiore rendendo uguali i dodici semitoni della scala. La moglie, di ritorno dopo anni di assenza, chiede al giovane Jonas di convincere il teorico della musica a prendere il comando di un’associazione che ha lo scopo di epurare la città e riportare l’ordine. Ma Eszter si rifiuta, mentre la gente arriva da ogni luogo a riempire le vie della città. Una notte la furia divampa e una folla di uomini armati di bastoni mette a sacco l’ospedale. All’alba resta solo la carcassa della balena allungata sulla piazza mentre fissa il mondo col suo occhio morto.
raitre.rai.it


Le armonie di Werckmeister, film che consiste di 39 inquadrature in 145 minuti di durata, rappresenta una sorta di marchio di fabbrica della poetica di Tarr: uno stile estremamamente formale, calcolato fin nel minimo dettaglio, con personaggi che si muovono all'interno dei piani come ballerine di prima fila del Bolscioi, ed oggetti che dosano luci ed ombre con precisione farmaceutica, su un bianconero dall'espressività addirittura dolorosa. Il film, che si basa su un racconto di Laszlo Krasznahorkai (Az ellenállás melankóliája - La malinconia della resistenza, 1989), è così denso di espressioni simboliche da lasciare sconcertati nel tentativo di risolverne gli enigmi metaforici, quasi come se il regista - termine che davvero, in questo caso, merita la sostituzione con "autore", se non "artefice" - avesse chiamato lo spettatore a partecipare ai propri sogni, incubi, desideri, allucinazioni, domandandogli solamente di lasciarsi andare alla danza della macchina da presa, al ritmo martellante delle scene scandite dal passo incalzante dei personaggi. Il limite di Tarr, come lui stesso sostiene, si chiama Kodak: "quella fottuta Kodak che fa bobine di soli trecento metri, poco più di dieci minuti... Una sorta di censura...".
sentieriselvaggi.it


La genesi del film è essa stessa una storia di vita difficile, con i suoi problemi di reperimento dei finanziamenti, di salute dei componenti del cast, di condizioni meteorologiche avverse; le difficoltà delle riprese - durate tre anni, ma con soli 68 giorni di girato vero e proprio - rispecchiano la precarietà dell'equilibrio del microcosmo rurale indagato da Tarr: un universo obsoleto, che si scontra con le esigenze della modernità e del mutamento, pretese dall'avvento della società dei consumi. Ma questa è una interpretazione sociologica: solo una delle deduzioni che possono derivare dalla visione del film, quando lo si collega al contrasto feroce tra i negozi luccicanti del Belváros di Budapest e il profilo monotono delle casupole immerse nel gelo novembrino, descritte dal regista. Il quale non solo non fa sociologia (caso mai psicodinamica delle masse), ma invita a considerare la sua opera come una luce gettata sulla realtà di un'Europa vicina, troppo vicina per non volerla vedere.
[...] Lontano come la luna dagli standard ai quali il predominio del marketing ci obbliga, nella forma della comunicazione come nella sostanza del comunicato: un cinema teso, sudato, che promette lacrime e sangue e restituisce gioia per il senso della vista.
sentieriselvaggi.it

VENERDI 19 FEBBRAIO 21.30
A Londoni férfi
(l’uomo di londra)
(inglese-francese subtitle italiano)
Di Béla Tarr

Regia: Béla Tarr, Ágnes Hranitzky
Sceneggiatura: Béla Tarr e László Krasznahorkai (dal romanzo di Georges Simenon)
Cast: Miroslav Krobot, Tilda Swinton, Ági Szirtes, János Derzsi, Erika Bók, Gyula Pauer, István Lénárt, Kati Lázár
Fotografia: Fred Kelemen
Montaggio: Ágnes Hranitzky
Musiche originali: Mihály Vig
Francia, Germania, Ungheria, 2007

Maloin conduce una vita semplice senza prospettive, al bordo di un mare infinito; nota a malapena il mondo attorno a sè, ed ha già accettato il lento ed inevitabile deteriorarsi della vita intorno a lui e la sua completa solitudine. Quando assiste ad un omicidio, la sua vita prende una svolta improvvisa.


Chiunque abbia letto Georges Simenon, creatore del Commissario Maigret, reca ben impresse nella mente le atmosfere che la sua penna riesce a creare, i suoi tempi narrativi, la galleria di personaggi che popolano i suoi libri.
The Man From London è un testo cupo, tutto racchiuso nel grigiore di una nebbia che tutto copre con il suo abbraccio. Bela Tar, superati i problemi (la morte del produttore Humbert Balsan) che avevano portato alla sospensione delle riprese nel 2005, porta in concorso il suo adattamento del romanzo, girato in un accattivante bianco e nero, con uno stile del tutto improntato alla staticità più assoluta.
Sin dall’inizio, lunghissimi piano-sequenza seguono come occhi impietosi azioni e personaggi, per poi risolversi nell’immobilità di un dettaglio che vede dilatarsi enormemente il suo ruolo sullo schermo, in modo non sempre del tutto giustificato. The Man From London è un film che la definire ’ostico’ rende solamente in parte una narrazione il cui incedere è appena percettibile.
Pur riconoscendo la bellezza di una soluzione registica come il piano-sequenza, sempre affascinante, va detto che una pellicola deve anche sapere mostrare altre qualità. Sbagliato sarebbe accontentarsi di un compiacimento visivo non accompagnato da una compiutezza che include anche narrazione e struttura. Bela Tar raccoglie l’invito insito nelle parole di Simenon a raccontare l’ineluttabilità e la drammaticità dell’essere umano nel confrontarsi con un destino che nessuna azione pare poter modificare. La scelta, quindi, di portare il ritmo della narrazione ad un livello bassissimo è celata dalla volontà di suggerire, attraverso la quasi totale assenza di movimenti di macchina, quella sospensione a metà tra realtà ed illusione in cui giacciono i suoi personaggi nel confronto insormontabile con la propria fine.
C’è, e si avverte tra le pieghe del film, il racconto di un continuo anelare verso una via di libertà e di giustizia, verso una rivalsa che prima appare possibile, ma che poi torna a naufragare. Noi spettatori siamo da subito messi a conoscenza delle colpe e delle virtù di ogni singolo personaggio ; altro implicito suggerimento del regista a concentrarsi su quello che la pellicola non mostra, ma incessantemente evoca.
The Man From London chiede un costante aiuto a chi lo guarda, chiede di essere tollerato ed interiorizzato per esplicare pienamente ciò di cui è costruito. Non c’è un giudizio applicabile, ma solo la necessità, probabilmente, di una seconda visione, inevitabilmente più consapevole. È un film che si può ammirare, ma assai difficile da amare.
di Salvatore Salviano Miceli da close-up.it
Il piano sequenza è la tecnica che più avvicina il cinema alla vita, nel senso che i nostri occhi inquadrano il mondo in piena continuità temporale (e quando li chiudiamo decidendo di privarci della visione non possiamo comunque fare nulla contro questa continuità, dato che il tempo e la vita continuano a fluire, ma solo sostituire l’immagine del mondo con l’immagine “nera”, o quella del sogno). Lo stacco di montaggio nel cinema di Béla Tarr ricorre raramente, e proprio per questo diventa importante, cruciale: l’inquadratura non va interrotta perché è come un’equazione danzante (lo stile di Tarr è una fusione tra danza e aritmetica) dentro la quale è l’esistenza stessa a muoversi. In alcune inquadrature di The man from London sembra addirittura che il tempo della vita si dilati, che il cinema non riesca ad abbandonare il presente, l’attimo in corso, per muoversi verso l’atto successivo. E Tarr ci fa respirare ogni attimo fin quando non ne abbiamo pieni i polmoni, solo allora si può finalmente “staccare”, e lo stacco è sempre un abbandono.
Inquadrature lunghe quelle di The man from London, talvolta eterne, in cui lo sguardo entra/esce frastornato, disorientato. L’impossibilità di cogliere ogni dettaglio della messa in quadro, di catalogare ogni finezza fotografica, di tracciare le coordinate della luce, è scombussolante, è come se nella perfezione chirurgica della fotografia (rigorosamente in bianco e nero) si nascondessero delle sfocature. Questa impossibilità fa confluire, seppur parzialmente, il fuori campo nel campo: c’è sempre qualcosa che non vediamo nel campo del visibile dato che possiamo concentrarci su pochi dettagli di un film che è un’esplosione di dettagli.
La prima inquadratura, assolutamente fetale (una “nascita”. Allo stesso modo il finale, la luce accecante, è una morte) ci porta fin sopra una nave, dal basso verso l’alto, una vera e propria iniziazione a quello che sarà il film (la prima inquadratura di ogni film di Béla Tarr da quasi sempre questa sensazione, basti pensare a quella, su alcune vacche, dell’epico, per durata e dimensioni, Satantango).
The man from London (si) gioca su due movimenti paralleli, da un lato la perlustrazione della superficie (questione prettamente contemporanea), dall’altro un movimento profondo all’interno delle superfici stesse. Potrebbe sembrare una presa di distanza, un’osservazione aritmetica delle forme ma è al contempo una osservazione partecipativa, pietosa e umanistica del profilmico, uno sforzo di riprendere la realtà in cui il cineasta ha già messo in conto il fallimento perché la realtà è più grande del quadro, solo parzialmente inquadrabile, vagamente osservabile.
Adattamento di un romanzo di Simenon questo film rappresenta una comunione tra il cinema di Tarr e le atmosfere tipicamente noir (in cui quindi il porto, il molo, il tracciare le coordinate ambientali sono importanti almeno quanto i personaggi) ed è pieno di zone d’ombra (in tutti i sensi), zone in cui il mistero e lo spaesamento confluiscono. Maloin, il protagonista del film, è l’uomo al cui lo sguardo pietoso di Tarr, letteralmente, si piega. Maloin è elemento estraneo (e dunque straniante), in aperto conflitto con l’ambiente, in piena deteriorazione interiore, uomo la cui moralità viene misurata con la moralità dello stile bélatarriano.
The man from London è un film che sprigiona un calore devastante e inesauribile, di un cineasta che sembra appartenere ad un’altra dimensione spazio-temporale, un combattente del cinema la cui arte si piega solo davanti all’uomo e a nessun’altra esigenza. Cinema come poesia cristallina, cinema vergine che lotta a denti stretti contro ogni tentativo di deflorazione.
Questi sottotitoli sono per la versione in due volumi AEN o per quella in un solo volume NON hardsubbata. I sottotitoli erano solo per le parti non in inglese, io li ho integrati aggiungendo ex novo i sub per le parti in inglese prendendoli dalla vecchia versione hardsubbata di pessima qualità.
ATTENZIONE, a meno che non sia già troppo tardi NON GUARDATE ASSOLUTAMENTE LA VERSIONE HARDSUBBATA perchè, oltrechè di qualità video molto scadente (e guardare bela tarr in quel modo è come guardare, chessò, miyazaki in bianco e nero), manca di un paio di sequenze, una della quali piuttosto importante per rendere intelligibile la trama.

VENERDI 26 FEBBRAIO 21.30
HUKKLE
(ungherese subtitle italiano)
Di György Pálfi
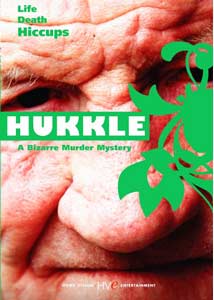
Un vecchio col singhiozzo si siede su una panchina e guarda. Intorno a lui il mondo naturale e quello degli uomini proseguono le loro lente, ripetitive esistenze come fossero un’unica cosa.
Ma un giorno, nel villaggio del vecchio, la gente inizia a morire. Per la precisione, i membri 'inutili' della comunità: quelli che non possono più lavorare, i disoccupati, gli anziani e i malati. E non muoiono di morte naturale…
Hukkle
Regia: György Pálfi
sceneggiatura: György Pálfi, Zsófia Ruttkay.
fotografia: Gergely Pohárnok.
montaggio: Gábor Marinkás.
musica: Samu Gryllus, Balázs Barna.
cast: Ági Margittay, Eszter Ónodi, Attila Kaszás,
Ferenc Bandi, Józsefné Rácz, József Forkas
produzione: Mokép, ORTT, MMK, TV2.
Ungheria, 2002, col, 75’

Hukkle è un film assurdo e misterioso. Se lo si guarda con disattenzione sembra quasi un documentario sulla vita di campagna. Ipnotizzati dai primi venti/trenta minuti di immagini e suoni che non rimandano ad altro se non a ciò che avviene in quel momento, senza un filo narrativo, rischiamo addirittura di non accorgerci di quanto inizia ad accadere da un certo momento in poi.
L’Ungheria, che conosciamo appena attraverso i film di Béla Tarr o i romanzi di Sandor Marai, si conferma ancora una volta come una terra di fascino e mistero, ma anche malata e inquietante.
La vita, sembra dire questo film, non vuol dire niente, non significa niente, così come il titolo del film: niente più che un suono onomatopeico di incerta provenienza.
PS: In questo film non ci sono dialoghi. Solo verso la fine alcuni personaggi si esibiscono in danze e canzoni, che hanno richiesto la traduzione dei sottotitoli. Ma il film si può considerare non muto (la colonna sonora, e in particolare i rumori, è fondamentale), ma afono.
Assomiglia alla risata di un vecchio.